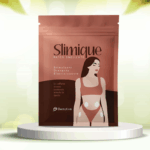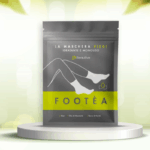La realizzazione della BreBeMi (A35), l’autostrada che collega la bassa bresciana con la periferia orientale di Milano, ha rappresentato uno degli esempi più discussi di project financing nel settore delle infrastrutture italiane. Annunciata come un’opera finanziata interamente da capitali privati, negli anni si è svelata una realtà molto diversa, con ingenti costi economici ricaduti sul settore pubblico e, in ultima analisi, sui cittadini.
Il progetto e il suo modello finanziario
L’idea iniziale alla base della BreBeMi era quella di creare una nuova arteria autostradale capace di alleggerire la pressione sulla vicina A4 Milano-Brescia. La costruzione avrebbe dovuto essere sostenuta dai ricavi dei pedaggi e, per questo, il rischio operativo e finanziario veniva formalmente trasferito ai privati coinvolti nel consorzio costruttore. Il costo stimato inizialmente si aggirava intorno agli 800 milioni di euro; tuttavia, a lavori ultimati, la cifra è salita vertiginosamente a circa 2,4 miliardi di euro se si considerano anche gli oneri finanziari legati ai prestiti bancari e agli interessi maturati nel tempo.
Il finanziamento fu sostenuto da importanti enti bancari come Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Europea per gli Investimenti. Al tempo stesso, il modello di “project financing” prevedeva che l’intera struttura di costi fosse ripagata unicamente con i ricavi generati dal pedaggio autostradale: una scelta rischiosa, legata alla previsione di flussi di traffico elevati e costanti nel tempo. Le stime interne, tuttavia, si sono rivelate ampiamente ottimistiche: invece dei 40.000 veicoli al giorno prospettati nei business plan, se ne sono registrati meno della metà.
Chi ha davvero pagato i costi della BreBeMi?
Contrariamente alla narrazione iniziale, secondo cui il costo sarebbe stato interamente assunto dai privati, nel corso degli anni il pubblico è intervenuto più volte per evitare il fallimento dell’infrastruttura. Dal 2016, la BreBeMi ha beneficiato di sostanziali contributi pubblici, per un totale di almeno 360 milioni di euro, tra stanziamenti statali e regionali. La struttura dei contratti siglati con lo Stato presentava clausole tali per cui, se i conti non fossero tornati, sarebbe intervenuto l’ente pubblico, garantendo la famosa “bancabilità” dell’operazione, ovvero la possibilità per le banche di rientrare dei propri crediti anche in caso di traffico inferiore alle attese.
Oltre ai fondi diretti, la convenzione prevedeva che, a fine concessione, i privati avessero diritto a oltre un miliardo di euro di indennizzo per subentro, una cifra che va a sommarsi ai costi già sostenuti dallo Stato per la gestione delle criticità finanziarie della società autostradale. Una situazione che ha di fatto mutato profondamente la natura dell’operazione: mentre gli introiti da pedaggio sono incassati da una società privata – oggi controllata dal fondo pensione australiano IFM tramite la società Aleatica – i costi delle difficoltà finanziarie sono stati ampiamente socializzati.
Meccanismo del project financing e impatti reali
Il caso BreBeMi è spesso indicato come esempio emblematico dei limiti strutturali del project financing all’italiana, dove il pubblico si trova a coprire le inefficienze o gli errori di valutazione dei privati. Il modello doveva essere teoricamente virtuoso: il privato si assumeva il rischio, investiva, gestiva e veniva remunerato dai pedaggi; lo Stato fungeva da semplice controllore. In realtà, la presenza di clausole di salvaguardia inserite nei vari passaggi contrattuali, ha garantito ai privati non solo una remunerazione fissa persino nei periodi di crisi, ma anche la possibilità di compensare direttamente dallo Stato le carenze di traffico e le mancanze di ricavi.
In particolare, spicca l’aumento del tasso di remunerazione del capitale investito, passato dal 3,59% del bando originale all’8,90% alla stipula delle nuove convenzioni: un parametro che ha reso molto allettanti i prestiti bancari, mentre i rischi di perdita rimanevano indirettamente, o direttamente, sulle spalle del pubblico. In aggiunta, l’aumento dei costi di costruzione, passato da meno di un miliardo a 2,4 miliardi, ha ulteriormente contribuito a ricadute negative sui bilanci della Regione Lombardia e, in misura minore, dello Stato centrale.
Le ripercussioni economiche e politiche
Un elemento chiave della vicenda BreBeMi consiste nelle conseguenze per le casse pubbliche, sia a livello regionale che nazionale. La Regione Lombardia, come lo Stato, ha contribuito direttamente con centinaia di milioni di euro per evitare il default della concessionaria. Oltre ai trasferimenti diretti, anche la sostenibilità della gestione futura grava sulle spalle dei contribuenti: il mancato raggiungimento degli obiettivi di traffico e ricavato viene ogni anno ripianato, almeno in parte, attraverso nuovi accordi, proroghe della concessione e iniezioni finanziarie.
Le scelte politiche che hanno contraddistinto la genesi e la gestione della BreBeMi sono state oggetto di forti polemiche. Da un lato, vi è la critica all’eccessiva fiducia nel project financing come soluzione “miracolosa” per le infrastrutture, dall’altro la denuncia di una prassi ormai diffusa in Italia dove il privato incassa gli utili, mentre le perdite vengono coperte dal pubblico. Questo meccanismo, ben distante dai princìpi originari delle concessioni, mina la credibilità del modello e genera sfiducia nella capacità dello Stato di controllare e indirizzare l’interesse collettivo.
Analisi costi-benefici e scenario futuro
Dal punto di vista strettamente tecnico, gli esperti di settore e la stessa Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno più volte sottolineato come la BreBeMi sia una tratta economicamente poco efficiente anche per questioni dimensionali. Tratte ottimali per garantire economie di scala e sostenibilità finanziaria sono superiori ai 180 chilometri; la A35, con i suoi 62 km, non riesce a raggiungere tali livelli, aggravando così l’impatto dei costi fissi e aumentando il fabbisogno di contributi pubblici, soprattutto in presenza di flussi di traffico inferiori alle attese.
Dal punto di vista ambientale, la realizzazione di un’infrastruttura di tale portata in aree agricole ad alta produttività ha provocato un impatto non trascurabile, aggravato dalla scarsa utilizzazione effettiva rispetto alle previsioni originarie. Questo fattore ha sollevato accesi dibattiti non solo sulla gestione finanziaria, ma anche sull’effettiva utilità dell’opera rispetto agli interessi della collettività.
Per i prossimi anni, resta da vedere come evolverà il rapporto tra la concessionaria privata – ora in mano a investitori stranieri – e il settore pubblico. Di certo, la vicenda BreBeMi rappresenta una lezione su come clausole contrattuali poco sagge e previsioni eccessivamente ottimistiche possano finire per riversare buona parte dei “costi astronomici” su chi, in realtà, avrebbe dovuto solo beneficiarne: i cittadini e i contribuenti italiani.